![]()
![]()
![]()
GEOGRAFIA - ITALIA - SARDEGNA
Medio Campidano (Provincia di)
La provincia del Medio Campidano - con capoluogo nei centri di Sanluri e Villacidro - conta 28 comuni, 106.720 abitanti (il 6,5% della popolazione sarda) e si estende per 1.516 kmq (il 6% circa del territorio sardo). La provincia è stata costituita nel maggio 2005. La sede provvisoria degli uffici è stata istituita a Sanluri. Fra i centri principali ricordiamo Guspini, Serramanna e San Gavino Monreale.Sanluri
(8.550 ab.). A metà strada fra Cagliari e Oristano, nella parte Sud-occidentale della Sardegna, il territorio di Sanluri si estende per circa 90 kmq ed è di natura collinare a Nord-Ovest e pianeggiante verso Sud. La sua economia, in origine prettamente agricolo-pastorale, si può oggi considerare sviluppata anche nei settori della piccola industria, del commercio e dei servizi. Sanluri è dal 2005 sede provvisoria della nuova provincia del Medio Campidano.STORIA. Sebbene la campagna di Sanluri sia stata abitata fin dall'epoca nuragica, la vera e propria storia per questo centro del campidanese ha inizio nel Medioevo. Da piccolo borgo si sviluppò rapidamente fino a divenire, agli inizi del XIV secolo, capoluogo della curatoria di Nuraminis, cui apparteneva. Tale crescita fu favorita dalla sua posizione strategica (al confine tra il Giudicato di Cagliari e quello di Arborea) e dalla fertilità delle sue terre. Proprio per la sua posizione Sanluri fu contesa durante le guerre tra gli Aragonesi e il Giudicato di Arborea: il Castello della città fu allora al centro di intricate vicende politiche e militari. All'inizio del 1400 gli Arborensi realizzarono un muro di cinta e scavarono un largo fossato: nonostante queste fortificazioni nel 1409 gli Aragonesi, capeggiati dal re Martino il Giovane, sconfissero i sardi nella battaglia detta appunto di Sanluri, saccheggiando e distruggendo il borgo. Nel 1436 divenne una viscontea, nel 1479 passò alla famiglia Castelvì che ne mantenne il possesso fino alla dominazione piemontese nel XVIII-XIX secolo. Dal 2005 è capolugo di provincia.
ARTE. Il Castello di Sanluri fu probabilmente eretto tra il XIII e gli inizi del XIV secolo e successivamente ampliato; è l'unico della Sardegna medievale a essere ancora abitabile, per quanto oggi adibito a museo. Tra il 1874 e il 1878 fu invece costruito il Palazzo municipale, mentre la bella chiesa parrocchiale di Nostra Signora delle Grazie, in stile tardo-barocco, fu ultimata tra il 1792 ed il 1794, sui resti di una chiesa risalente al XVI secolo, di cui si conserva solo la parte inferiore del campanile. Al suo interno è conservato il Retablo di Sant'Anna, polittico tardo-cinquecentesco dipinto a tempera su tavola.
Villacidro
(15.000 ab.) Centro della Sardegna sud-occidentale, 45 chilometri a nord-ovest del capoluogo sardo, capoluogo della provincia del Medio Campidano insieme a Sanluri. In età romana sorgeva probabilmente intorno a una villa patrizia ("villa citra"). Nel corso dei secoli, tuttavia, a svilupparsi fu Leni, villaggio popoloso e più vasto situato nella pianura intorno al fiume omonimo. Leni divenne, nel XIV secolo, il centro più ricco della Curatorìa di Gippi; poi decadde fino a scomparire alla fine del XVI secolo. Villacidro al contrario crebbe gradatamente e venne via via a contrapporsi a Leni.Nuoro
(36.900 ab.). La città di Nuoro sorge su un altopiano granitico a 532 m s/m. nei pressi del Monte Ortobene (955 m). Il suo territorio è considerato uno dei polmoni verdi del Mediterraneo. È centro agricolo (vini, olio, frutta) e commerciale, con industrie alimentari, edili, tipografiche, meccaniche, del legno e delle costruzioni elettriche. Nonché centro di servizi amministrativi e culturali. Importante inoltre il settore turistico.STORIA.
La storia medievale e moderna di Nuoro è legata a quella della sua diocesi. La città divenne infatti sede vescovile nel XII sec. e quando la diocesi fu annessa a Cagliari (1495) iniziò un periodo di decadenza da cui si riprese solo alla fine del XVIII sec. quando ritornò sede vescovile (1779). L'Ottocento si aprì con un periodo di relativa tranquillità, ben presto interrotto a seguito delle disposizioni regie che ponevano fine all'uso comunitario della terra (editto delle "chiudende", 1820).
Una serie di sollevazioni popolari ebbe il suo culmine nel 1868 con la rivolta "de Su Connottu" a causa dell'attuazione della legge del 1865 che aboliva gli usi e i diritti d'ademprivio (cioè la possibilità di far legna, raccogliere ghiande e funghi, allevare maiali sulle terre demaniali e nei latifondi).
Con la ricostituzione a capoluogo di provincia nel 1927 (in precedenza era stata sede di divisione amministrativa e di intendenza dal 1848 al 1859), la città conobbe un nuovo sviluppo urbanistico: numerosi edifici pubblici sorsero nei dintorni di via Deffenu, di via Dante e di piazza Crispi; gli abitanti passarono dagli 8.500 del 1921 agli oltre 11.000 del 1939. Il secondo dopoguerra vide un'ulteriore accelerazione del processo di urbanizzazione, insieme al progressivo mutamento della caratterizzazione agro-pastorale della città in favore di quella amministrativo burocratica.
ARTE.
D'interesse artistico è il Duomo di S. Maria della Neve (XIX sec.) che divide l'antico centro della città dai recenti quartieri residenziali e conserva nel presbiterio una bella tela con Cristo morto, attribuita ad Alessandro Tiarini. A pochi chilometri dalla città è la chiesetta di Nostra Signora della Solitudine. Tale edificio è spesso menzionato nei romanzi di Grazia Deledda, scrittrice nuorese premio Nobel per la letteratura nel 1926, le cui spoglie sono qui tumulate. Altro illustre letterato della città fu il poeta Sebastiano Satta (1867-1914). Di notevole interesse sono poi i numerosi reperti archeologici (domus de janas, nuraghi) sparsi nei dintorni della città.
LA PROVINCIA.
La provincia di Nuoro (dal 2005) conta 52 comuni e 165.570 abitanti (il 10,1% della popolazione sarda), e si estende per 3.934 kmq (il 16,5% circa del territorio sardo). Il territorio è perlopiù collinare e montuoso e culmina nel massiccio del Gennargentu. Risorsa principale è l'agricoltura i cui prodotti sono cereali, patate, ortaggi, frutta, uva (produzione di vini pregiati), olive. Importanti sono la pastorizia e l'allevamento ovino che alimentano l'industria lattiero-casearia. Alle industrie alimentari si affiancano industrie estrattive, tessili, conciarie. Notevole è la produzione artigianale di tessuti di orbace, lino, tappeti, arazzi, cuoio lavorato, terrecotte, filigrane e ferro battuto. Fra i centri principali ricordiamo: Bitti, Dorgali, Fonni, Macomer, Oliena, Orgosolo, Orosei, Orune, Siniscola.
Veduta di Nuoro dal monte Ortobene
![]()
![]()
Luoghi d'interesse
La Cattedrale
Nella piazza alberata di S. Maria della Neve, sorge l'omonima Cattedrale dalla neoclassica facciata con frontone, colonne ioniche e due campanili laterali. Decentrato rispetto alla zona più rappresentativa della città, il Duomo di Nuoro fu costruito a partire dal 1836 e terminato nel 1854. L'interno custodisce alcuni dipinti di un certo pregio: nella prima cappella a destra, una pala di Bernardino Palazzi; alla parete fra la prima e la seconda cappella, una tela con Disputa di Gesù fra i dottori attribuita a Luca Giordano; in fondo alla navata, una Deposizione del Palazzi. I pannelli della Via Crucis sono per metà di Carmelo Floris e per l'altra di Giovanni Ciusa Romagna. Alla parete destra del presbiterio, un Angelo che piange sul Cristo deposto, a lungo attribuito ad Alessandro Tiarini, forse dei primi dell'Ottocento.Museo d'Arte della Provincia di Nuoro
Il MAN, Museo d'Arte della Provincia di Nuoro, è situato in una palazzina di via Satta: dei quattro piani espositivi, il primo e il secondo presentano una selezione di opere di artisti sardi del Novecento, prevalentemente di area nuorese. Di particolare rilevanza sono le opere di Antonio Ballero, Mario Delitala, Giovanni Ciusa Romagna, Carmelo Floris, Francesca Devoto, Mauro Manca, Maria Lai, Costantino Nivola e Gino Frogheri. Il museo dedica grande impegno nell'organizzazione di mostre temporanee, che vengono allestite nel piano terra e al quarto piano dell'edificio.Museo Deleddiano
è allestito, dal 1983, al n. 28 di via Grazia Deledda, nella casa in cui la scrittrice nacque nel 1871. Il museo, completamente rinnovato nel 2000, è di proprietà dell'ISRE (Istituto Superiore Regionale Etnografico): raccoglie oggetti personali, fotografie, autografi, prime edizioni italiane e straniere delle opere, note di stampa e testimonianze varie attinenti alla vita e all'attività di Grazia Deledda. La casa è un dignitoso esempio di abitazione nuorese, adeguata per dimensioni e aspetto alle esigenze di una famiglia agiata della seconda metà dell'Ottocento. Un attento restauro le ha restituito l'originaria qualità architettonica, collegando l'organizzazione degli spazi ai caratteri dell'allestimento espositivo. In una parte delle stanze del pianterreno, del cortile e dell'ammezzato sono ricostruiti gli ambienti descritti nell'opera autobiografica Cosima.Museo della Vita e delle Tradizioni popolari sarde
Sorge sul colle di S. Onofrio, in un complesso realizzato agli inizi degli anni '60, aperto al pubblico dal 1976. Gli edifici, disegnati dall'architetto Antonio Simon, presentano una tipologia e una distribuzione spaziale tendenti a ricostruire un ideale villaggio sardo tradizionale. Di particolare interesse per ricchezza e varietà risultano la collezione di vestiario popolare festivo e quotidiano (fine '800 - prima metà del '900), il repertorio di amuleti d'argento e in pietre e materiali vari, la raccolta di ornamenti preziosi e i materiali tessili. Si segnala inoltre la sezione dedicata alle maschere tradizionali del Carnevale barbaricino (i mamuthones di Mamoiada, i thurpos di Orotelli e i merdùles di Ottana), nonché l'esposizione di pani festivi e cerimoniali e di dolci del Nuorese.Necropoli di Maria Frunza-Ianna Ventosa
Il complesso ipogeico, scavato in un'altura rocciosa alle pendici del monte Ortobene, è costituito da cinque sepolture: la tomba di Janna Ventosa e le quattro tombe dette di "Maria Frunza". La tomba di Janna Ventosa - la più conosciuta - è di tipo misto: alla grotticella artificiale è stato addossato un corridoio megalitico. Dal portello d'ingresso - con soglia costituita da una pietra trapezoidale - si accede all'anticella rettangolare; le pareti del vano sono lisciate a martellina, sul pavimento sono presenti un focolare rituale e una fossetta ovoidale. La necropoli risale al Neolitico finale (cultura di Ozieri, 3200-2800 a.C.) - Eneolitico (cultura di Monte Claro, 2400-2100 a.C.; cultura del Vaso Campaniforme, 2100-1800 a.C.).Ogliastra (Provincia di)
La provincia dell'Ogliastra, con capoluogo nei centri di Lanusei e Tortolì, conta 23 comuni, 54.690 abitanti (il 3% circa della popolazione sarda) e si estende per 1.854 kmq (il 6,2% del territorio sardo). è la provincia meno popolata d'Italia. Fanno parte del territorio provinciale i due Laghi del Flumendosa. La provincia è stata costituita nel maggio 2005. La sede provvisoria degli uffici amministrativi è stata istituita a Lanusei. Fra i centri principali vi sono Barisardo e Baunei.Lanusei
(6.000 ab.). Comune della Sardegna Centro-orientale, situato sulle pendici che dal Gennargentu discendono verso la costa tirrenica. Dal 2005 capoluogo (provvisorio) della nuova provincia dell'Ogliastra. Il territorio è ricco di foreste e sorgenti d'acqua, famose per le loro qualità curative. Numerose le testimonianze archeologiche databili all'epoca nuragica. L'attività economica prevalente è il terziario.STORIA E CARATTERISTICHE.
Numerosi reperti testimoniano come l'area fu abitata sin dal Neolitico. Presso il bosco Selene sono stati ritrovate due domus de janas risalenti a un periodo compreso tra il XV e il XVIII secolo a.C.; mentre tracce di insediamenti umani, risalenti al II e al I secolo a.C., sono stati rinvenuti anche nella valle del rio Mesuidda. In epoca medioevale Lanusei fu incorporato nella contea di Quirra. Con l'editto del 27 luglio 1838 vi fu istituito il tribunale collegiale, composto da un prefetto, tre assessori, un avvocato, un procuratore fiscale, un avvocato dei poveri, un procuratore e un segretario. Nel 1898, a seguito dell'arrivo dei Salesiani, il centro divenne il primo laboratorio culturale dell'Ogliastra, con l'apertura di numerose scuole e ginnasi.
Tortolì
(10.207 ab.) Città della Sardegna centro-orientale che costituisce con Lanusei la provincia dell'Ogliastra. Appartiene alla Diocesi dell'Ogliastra, di cui è stata sede vescovile fino al 1927.Olbia-Tempio (Provincia di)
La provincia di Olbia-Tempio conta 26 comuni, 139.640 abitanti (l'8,5% della popolazione sarda) e si estende per 3.397 kmq (il 14,2% del territorio sardo). La provincia è stata costituita nel maggio 2005. La sede degli uffici amministrativi è stata istituita a Olbia e a Tempio Pausania. Dal punto di vista economico sono molto importanti per la provincia l'estrazione e la trasformazione del sughero e del granito, nonché l'industria turistica legata alle zone costiere più rinomate dell'intera Sardegna (dalla Costa Smeralda alla Baia Sardinia, dalla Costa Paradiso al Golfo Aranci, all'Arcipelago della Maddalena). Fra i centri principali ricordiamo Arzachena, La Maddalena, Palau, Santa Teresa di Gallura.Olbia
(46.250 ab.). Situata sulla costa Nord-orientale della Sardegna, Olbia si estende in un tratto di pianura sulla riva dell'omonimo golfo. La città è in forte espansione per lo sviluppo delle attività legate al turismo, ai traffici portuali, al commercio, ai servizi e a numerose imprese industriali, alcune delle quali di grande rilievo. Il porto, intorno al quale ha sempre gravitato l'economia olbiese, è l'approdo sardo più adatto alla navigazione da e per la penisola: il movimento passeggeri è cresciuto talmente negli ultimi anni da far diventare lo scalo uno dei primi in Italia. Anche le grandi navi da crociera hanno intensificato le loro soste a Olbia, con un centinaio di approdi a stagione, e notevole importanza ha raggiunto altresì il traffico merci. Altro fattore fondamentale per lo sviluppo di Olbia (e dell'intera provincia) è stata la crescita progressiva dell'aeroporto "Costa Smeralda". Olbia è un centro noto anche per le specialità enogastronomiche: nelle acque del suo golfo vengono coltivati frutti di mare, soprattutto cozze, e nella sue cantine si producono vini Docg di Gallura (Vermentino), Doc di Gallura (Moscato), Doc di Sardegna (Cannonau di Sardegna). Olbia dal 2005, insieme alla città di Tempio Pausania (14.000 ab.), è capoluogo della nuova provincia gallurese denominata di Olbia-Tempio.STORIA.
Secondo la mitologia greca fu Iolao, figlio di Ercole, il primo fondatore della città. In realtà una fondazione greca di Olbia è ancora in forse (tuttavia olbìa polis, in greco, starebbe a indicare una "città felice"); mentre è certa la presenza di una colonia fortificata cartaginese, intorno alla metà del IV secolo a.C.: infatti, un tratto delle mura occidentali, insieme con la porta d'ingresso affiancata da torri, è ancora visibile in Via Torino a testimoniare l'importanza anche urbanistica della colonia punica. Nel 259 a.C. fu occupata dai Romani, della cui dominazione conserva diversi reperti (foro, strade lastricate, terme pubbliche, acquedotto, ecc.). Decaduta la città romana a causa delle incursioni prima vandaliche (466) e poi arabe e piratesche, cui si aggiunse l'interramento del porto e la diffusione della malaria nella fascia costiera, dopo la riconquista della Sardegna da parte di Bisanzio (534) risorse verso la fine del VI sec. nell'entroterra con il nuovo nome di Phausiana, periodo in cui vi è attestata la presenza di una sede vescovile, una delle più antiche dell'isola. Nel Medioevo, precisamente dal 1113, la città è nuovamente collocata nel sito originale con la denominazione di Civita, divenuta ora la capitale del Giudicato di Gallura. Nel Trecento, la fine del Giudicato e l'occupazione pisana determinarono il nuovo cambio del nome con quello più toscano di Terranova. La successiva occupazione spagnola la affidò a diverse famiglie feudali, tra le quali i Borgia. Le cose cominciarono a migliorare lentamente a partire dal XVIII, allorché la Sardegna passò ai Savoia; Terranova cominciò ad avvantaggiarsi della politica riformistica di Carlo Emanuele II, che reinserì la Gallura nel circuito degli scambi tra la Corsica, la Francia del Sud e Genova. La ripresa divenne accelerata con la riunificazione del Regno d'Italia e lo spostamento della capitale a Roma (1870), che rese nuovamente privilegiato il porto di Terranova. Nel corso del Novecento, e proprio a seguito dello sviluppo del porto, la città si ampliò assumendo prima il nome di Terranova Pausania, e poi, nel 1939, con la rivalutazione delle tradizioni romane, quello più antico di Olbia. Durante la seconda guerra mondiale, venne bombardata varie volte visto l'importanza strategica e la presenza nel suo territorio del porto e dell'idroscalo. Superato il periodo della ricostruzione, la città fece registrare un vero e proprio "boom" demografico ed economico a partire dagli anni Sessanta, con la creazione del Consorzio della Costa Smeralda, presentato ufficialmente dall'Aga Khan il 22 gennaio 1962 alla Regione Sarda e al comune di Olbia. Da quel momento decollò lo sviluppo turistico di tutta l'area Nord-orientale della Sardegna. Attualmente Olbia conta quasi 50.000 abitanti e costituisce, grazie al porto e all'aeroporto, il più importante scalo-passeggeri della Sardegna e uno dei più importanti d'Italia.
ARTE.
L'attuale territorio di Olbia fu abitato dai nuragici, dei quali presenta un notevole numero di siti e rovine preistorici, tra cui il pozzo sacro di Sa Testa (risalente al periodo compreso tra l'VIII e il VI secolo a.C.), la tomba di giganti di Su Monte 'e s'Abe (sepoltura megalitica collettiva, originaria dell'Età del Bronzo antico e rimaneggiata in età nuragica) e il nuraghe Riu Mulinu a Cabu Abbas.
La città di Olbia mostra la sua antica nobiltà soprattutto con la bella Cattedrale di San Simplicio, tutta costruita in granito, a tre navate, absidata e con campanile a vela, appartenente al gruppo delle chiese romaniche isolane più datate (risalenti all'XI-XII secolo). Nel centro storico si sono poi conservati esempi di case e palazzi antichi, mentre nelle vie parallele della parte vecchia si incontrano le basse e tipiche casette unifamiliari intonacate a tinte vivaci. Molto suggestivi, infine, i resti del medievale Castello di Pedres, pochi chilometri a Sud della città: il fortilizio, di cui si hanno notizie scritte tra il 1296 e il 1388, realizzato probabilmente da maestranze pisane-lucchesi importate durante il dominio della famiglia Visconti nel regno giudicale di Gallura, un tempo era costituito da due piazzali cinti da mura turrite e dominava il settore meridionale del Golfo di Olbia. Il mastio centrale, conservato per un'altezza di oltre 10 m, è la parte più spettacolare del complesso: presenta ingresso sopraelevato (di 3,75 m) dal piano roccioso di fondazione e originariamente era suddiviso in quattro ripiani lignei, con in cima un terrazzo pavimentato in cocciopesto.
Tempio Pausania
(14.000 ab.). Capoluogo della provincia gallurese di Olbia-Tempio, insieme a Olbia. Situato a 566 m s/m., sui contrafforti del monte Limbara, è noto per l'industria del sughero, l'estrazione del granito, la viticoltura e lo sfruttamento di sorgenti di acqua termale. Il suo centro storico presenta una tipica architettura di palazzi in blocchi di granito con marcate similitudini rispetto ai centri del Sud della Corsica. Il nome di "Tempio" compare per la prima volta in un documento del 1173, contenente un accordo tra il vescovo di Civita (l'attuale Olbia) e la città di Pisa. Sino al primo dopoguerra Tempio, con il suo vastissimo territorio comunale, abitato dai pastori degli stazzi, costituisce un'eccezione nel panorama sardo fatto di vasti spazi disabitati. Nel secondo dopoguerra, tuttavia, si evidenziano alcuni sintomi di crisi aggravati dal progressivo e inarrestabile ritorno della popolazione verso le coste. Dal 2005, il rilancio di Tempio Pausania è altresì affidato alla nascita della nuova provincia di Olbia-Tempio e alla localizzazione in città di parte degli uffici provinciali. Di notevole pregio architettonico è il Santuario dei Santi Cosma e Damiano, nella frazione di Nuchis: esso venne fondato nel 1529 dopo una peste, ricostruito nel 1835 e restaurato nel 1945. Interamente in granito con facciata a spioventi e campanile a vela sulla sommità, è ad aula mononavata, con volta a botte divisa da cinque arcate. Gli affreschi sono di Carlo Armanni.Oristano
(31.700 ab.). La città di Oristano è situata all'interno del golfo omonimo alla sinistra del fiume Tirso. È un attivo centro commerciale, culturale e industriale (zuccherifici, risiere, cartiere, stabilimenti vinicoli, industrie alimentari, della ceramica, meccaniche). Importante è la produzione artigianale di brocche e stoviglie in terracotta, ricami, ceramiche, lavorazione del legno e ferro battuto. La pesca è diffusa negli stagni lungo la costa. STORIA. Gli uomini del Neolitico e dell'Eneolitico (V-III millennio a.C.) popolarono ogni lembo del territorio circostante, deponendo i loro morti nelle fosse o nelle domus de janas di Cabras e di San Vero Milis. Fra il 2500 e il 1800 a.C. sorsero i primi nuraghi. Ma dopo l'età dei Fenici e dei Cartaginesi e il dominio romano e vandalico, con il periodo bizantino l'insicurezza dei mari porterà a un progressivo spopolamento dei territori costieri, di Tharros e del Sinis in particolare.Oristano venne fondata verso il 1070 proprio dagli abitanti di Tharros che avevano abbandonato la loro città a causa delle incursioni saracene. Divenuta capitale del Giudicato di Arborea raggiunse la massima prosperità economica nel XIII sec. Dopo il periodo eroico della giudicessa Eleonora (scomparsa nel 1404), nel 1478 si arrese definitivamente agli Aragonesi e sprofondò per due secoli in uno stato di crisi e prostrazione. Passata ai Savoia nel 1720, da allora seguì le vicende storiche del Regno di Sardegna. Con l'ordinamento amministrativo del nuovo Regno d'Italia, Oristano fu prescelta a capoluogo del circondario, comprendente 105 comuni. Cessò di esserlo con le soppressioni delle sottoprefetture nel 1927, quando venne inserita nella provincia di Cagliari. Nel 1953 fu presentato un disegno di legge per istituire in Sardegna una quarta provincia con capoluogo Oristano. Tale disegno fu accolto nel luglio del 1974, quando divenne capoluogo dell'attuale Provincia omonima (il cui territorio è stato ritoccato nel 2005).
ARTE.
Torri medievali, il campanile-ottagono della Cattedrale, le cupole di chiese e palazzi rivestite di tegole iridescenti e le altissime palme verticalizzano lo skyline della città, conferendole un'atmosfera andalusa orientaleggiante, retaggio del Medioevo, quando Oristano era la capitale di un regno (il giudicato d'Arborèa) e gli ultimi giudici-re combattevano tenacemente contro le armate degli invasori catalano-aragonesi. Il centro della città è dominato dalla poderosa Torre di S. Cristoforo (o Porta Manna), resto della cinta difensiva costruita nel 1291. Principale edificio monumentale è il Duomo, risalente anch'esso al periodo medievale, ma rifatto nel 1733. Poco distante dalla città scavi archeologici hanno messo in luce le rovine di Tharros, antico centro fondato dai Fenici, passato in seguito sotto il dominio di Cartagine e Roma e poi abbandonato nell'Alto Medioevo a causa delle scorrerie arabe. Parte delle rovine si trova oggi sommersa dal mare antistante per effetto del bradisismo.
LA PROVINCIA.
La provincia di Oristano (dal 2005) conta 88 comuni, 169.271 abitanti (il 10,3% della popolazione sarda) e si estende per 3.040 kmq (il 12,8% del territorio sardo). Fanno parte del territorio provinciale il Lago Omodeo, lo Stagno de is Benas, lo Stagno di Cabras e lo Stagno di Santa Giusta. Prodotti dell'agricoltura sono la barbabietola da zucchero, la vite (rinomato è il vino vernaccia) e le fragole. Diffuso è l'allevamento nelle zone di montagna e sviluppata è la pesca (golfo di Oristano, stagni e lagune). Le industrie principali sono quelle petrolchimica, dei materiali da costruzione, vinicola e manifatturiera. Importante è l'artigianato: ricami, terrecotte, ceramiche, ferro battuto, lavorazione del legno. Fra i centri principali ricordiamo: Arborea, Bosa, Cabras, Cuglieri, Ghilarza, Marrubiu, Mogoro, Samugheo, Santulussurgiu, Terralba, Uras.
Luoghi d'interesse
La Cattedrale
Risalente al XIII secolo d.C., la Cattedrale di Santa Maria Assunta, così come appare oggi, è il frutto di una ricostruzione in forme barocche del 1721-33, a opera dell'architetto Giovanni Battista Arieti di Alghero. L'alto campanile ottagonale risale tuttavia al sec. XV, ad eccezione della cella campanaria e dell'iridescente cupola a corona imperiale, del XVIII secolo. L'interno a croce latina presenta una navata unica con transetto terminato alle testate da cappelloni neoclassici. Il presbiterio sopraelevato è ornato da tele di Giovanni Marghinotti (sec. XIX) e, al centro, da una tela ovale di Vittorio Amedeo Rapous raffigurante l'Assunta (sec. XVIII). Notevoli, una statua lignea policroma dell'Annunciata di Nino Pisano (sec. XIV) e due frammenti di amboni romanici della prima metà del sec. XII con Daniele nella fossa dei leoni e Due leoni che abbattono due cerbiatti. Nel sec. XIV i marmi furono riusati come predella di ancona e scolpiti con scene bibliche e di santi da un artista barcellonese. Nel transetto destro si apre la gotica Cappella del Rimedio (sec. XIV), con volta a crociera gemmata; sulla parete destra è l'iscrizione funeraria del canonico giurista Filippo Mameli che reca la data 1349. Nel sagrato si conserva, in un ambiente ipogeo, la scalinata d'accesso all'originario Duomo romanico e gotico, nonché alcune tombe a cassone bizantine del VI secolo.Chiesa di San Francesco
La chiesa attuale, neoclassica, con pronao ionico e aula a impianto centrale cupolato, venne realizzata dal cagliaritano Gaetano Cima nel 1840, sulle rovine di un precedente tempio gotico risalente alla metà del XIII secolo. All'interno della chiesa è collocato, sull'altare a sinistra, il Cristo crocifisso, detto di Nicodemo, massima espressione della scultura lignea di ambiente catalano del sec. XV presente in Sardegna. Altro capolavoro scultoreo è la statua di San Basilio Vescovo, di Nino Pisano, scolpita intorno all'anno 1368. Lo splendido chiostro gotico della metà del XIII secolo, riformato secondo il gusto catalano nel XVI secolo, è in corso di restauro.Piazza Eleonora
Vi sorge il monumento marmoreo alla giudicessa Eleonora d'Arborèa eseguito nel 1881 da Ulisse Cambi. Sulla sinistra è il Palazzo comunale (edificato nel XVII sec.), già neoclassico convento degli Scolopi. Non lontano, in via Parpaglia, sorge la cinquecentesca Casa di Eleonora.Torre di San Cristoforo o Torre di Mariano II
A pianta quadrilatera e costruita in blocchi di arenaria, la Torre di San Cristoforo è la parte più visibile dei resti delle antiche mura giudicali, era infatti una delle porte di ingresso alla città (attraverso l'ogivale Porta Manna). La torre è situata nell'attuale piazza Roma, fu eretta nel 1291 insieme alle mura per volere di Mariano II, giudice di Arborea. La costruzione è tozza e massiccia, formata da tre piani sovrapposti, sull'ultimo è situata una torretta merlata più piccola, dove ha sede una campana del 1430; la parte rivolta verso la città è aperta, mentre gli altri tre lati rivolti verso l'esterno sono chiusi. Fu detta di San Cristoforo poiché al suo interno venne inserito un retablo del santo, protettore dei viandanti, forse sin dal XV secolo. Altri resti delle antiche mura si possono vedere in via Cagliari, in via Mazzini, e in via Contini.Antiquarium Arborense
Museo archeologico (e Pinacoteca) di Oristano, costituito nel 1938 con l'acquisto della raccolta di arte arcaica dell'avvocato Efisio Pischedda. La parte più interessante della collezione, allocata nell'ottocentesco Palazzo Parpaglia, comprende utensili in ossidiana e vasellame dai centri preistorici del Sinis, una ricca serie di vasi votivi (secc. XII-X a.C.) dal nuraghe Sianeddu di Cabras, alcuni bronzi nuragici e il più ampio complesso di corredi funerari delle tombe fenicie e puniche di Tharros, tra cui una maschera ghignante in terracotta.Chiesa di Santa Chiara
Eretta intorno al 1343, si presenta con una sobria facciata di conci di arenaria, arricchita da due monofore cieche e da un rosone. L'interno, recentemente restaurato, mostra l'originaria cappella presbiteriale con volta a crociera e bifora inquadrata da un arco acuto sul fondo. Già sede di un monastero di Clarisse (forse il più antico di Sardegna), custodisce l'iscrizione sepolcrale, in caratteri gotici, della giudicessa Costanza di Saluzzo, nonna di Eleonora d'Arborèa, ivi sepolata nel 1348.Nostra Signora del Carmine
Notevole esempio di architettura barocco-piemontese, la chiesa fu edificata dall'architetto Giuseppe Viana tra il 1766 e il 1785.Area archeologica di Tharros
Già antico scalo commerciale fondato dai Fenici tra l'XI e l'VIII secolo a.C., collocato sul promontorio che dal Sinis si protende a Sud sino a Capo San Marco, dalla parte Nord-occidentale del Golfo di Oristano. Quella di Tharros era, come Corinto, una "città bimare": i Fenici, infatti, tendevano a edificare le loro colonie in penisolette affusolate, affinché le navi al momento dell'approdo potessero riparare in una delle due rade, a dispetto di qualsiasi direzione avessero i venti. Tharros è oggi un'area archeologica di notevole interesse, sede di scavi dal 1956. Entrando nel sito, che si presenta per lo più come centro tardo-romano, anche se non mancano le testimonianze cartaginesi e altomedievali, si percorre una strada lastricata in basalto che conduce a una piazzetta, il compitum, con un'edicola consacrata ai Lares Compitales. Nella parte settentrionale si trova un edificio quadrangolare, che fungeva da serbatoio dell'acquedotto e che alimentava una fontana pubblica. Risalendo verso la strada principale, al cui centro sono le fognature, e ai cui lati c'erano negozi e locali di ristoro, si arriva in un'arena delimitata da un terrapieno: è l'anfiteatro, risalente ai sec II-III d.C., che occupa, in parte, l'area del tophet, un antico santuario a sua volta costruito sui resti di un villaggio nuragico. Poco oltre si distinguono le torri quadrate e i resti delle fortificazioni della città. Le mura, in arenaria, risalenti all'epoca cartaginese, sono state cancellate da quelle romane. Tornando al compitum e svoltando poi verso sinistra, si trova il complesso delle terme III, mentre sulla destra sono i resti del tempio cartaginese delle semicolonne doriche (III secolo a.C.). La strada finisce di fronte alle terme I (II secolo d.C.), che i Cristiani del V secolo utilizzarono per costruire una basilica con battistero a vasca esagonale. Sulla destra vi sono i resti di quello che probabilmente era un tempio a quattro colonne risalente circa al 50 a.C. Proseguendo s'incontra il Foro di Tharros, un piazzale di forma trapezoidale nel quale si svolgeva la vita pubblica della città, delimitato dalle Terme II, o Terme del foro (200 d.C.).Le lagune di Cabras
Il golfo di Oristano, sulla costa occidentale della Sardegna, è una zona estremamente interessante dal punto di vista naturalistico per la rara bellezza e varietà del paesaggio, punteggiato da stagni e lagune dove nidificano uccelli acquatici come lo svasso maggiore, l'airone rosso, il tarabuso, il gobbo rugginoso, il falco di palude, l'avocetta, il cavaliere d'Italia e tanti altri. Tra Marceddì e Oristano si trovava un tempo lo stagno di Sassu, il più grande stagno costiero della regione che venne prosciugato al tempo della bonifica della piana di Arborea (1919-1925). La penisola del Sinis, a Nord del golfo, fra il mare aperto e l'ampio stagno di Cabras, è molto suggestiva sia per i numerosi stagni (Cabras, Mistras, Marceddì, Sale Porcus, Santa Giusta), sia per i resti archeologici (Tharros) che testimoniano delle civiltà che popolarono un tempo questa terra selvaggia. Centro principale è il villaggio di San Giovanni, con tipiche case in canna di palude, un tempo rifugio dei pescatori. Le località maggiormente suggestive sono lo stagno di Cabras e quello di Sale Porcus. Il primo, alimentato dal Riu di Mare Foghe e comunicante col mare grazie a un sistema di canali artificiali, è solcato da caratteristiche imbarcazioni fabbricate con le canne della palude che ricordano le antiche barche di papiro; il secondo è completamente asciutto d'estate perché, non essendo alimentato né dal mare né dai fiumi, dipende dall'apporto delle acque piovane.Sassari
(121.100 ab.). La città di Sassari, secondo centro urbano in Sardegna dopo Cagliari per consistenza demografica e per importanza economica, politica e culturale, è situata a 225 m s/m. al centro di un tavolato calcareo che si apre su una fertile piana (la Nurra), digradante a Nord verso il Golfo dell'Asinara. I litorali del sassarese presentano una varietà paesaggistica che alterna tratti di spiagge bianche, come quelle di Platamona e Stintino, e chilometri di coste rocciose e frastagliate. L'economia è basata sul settore terziario (servizi, commercio e turismo), affiancato dalle produzioni agricole, di cui particolarmente sviluppate quelle olearia, vinicola, ortofrutticola e casearia. Di grande rilevanza, a livello industriale, la lavorazione del sughero. Le altre industrie principali sono pastifici, concerie, cotonifici, calzaturifici e meccaniche.STORIA. Le tracce risalenti all'età preistorica presenti nel territorio dell'odierno Comune di Sassari sono concentrate verso Porto Torres; si ritiene che in età romana esso costituisse l'entroterra di Turris Libissonis (l'attuale Porto Torres), allorché questa colonia romana attraversava il periodo della sua massima importanza. Il primo nucleo propriamente urbano di Sassari fu invece fondato nel XII secolo dalle popolazioni della zona costiera in fuga dalle incursioni barbariche. Il nome "Sassari", infatti, è citato per la prima volta in un antico registro risalente al 1131 d.C. ritrovato nel monastero di San Pietro in Silki, alla periferia della città. Lo sviluppo del villaggio venne favorito dalla posizione particolarmente felice, al centro del Giudicato di Torres (o Logudoro), divenendo ben presto un importante e popoloso centro commerciale. Nonostante fosse sotto la protezione di Pisa, Sassari divenne libero Comune nel corso del XIII secolo (i suoi Statuti comunali del 1294, tesi a regolare tutti gli aspetti della vita urbana e i rapporti con il contado, sono fra i più antichi ordinamenti giuridici della Sardegna). Nei secc. XIV e XV fu uno dei centri della resistenza al dominio aragonese, seguendo poi le vicende storiche della Sardegna conquistata. Sotto l'amministrazione dei vicerè spagnoli iniziò per la città un periodo di decadenza (fu altresì colpita, nel 1652, da una terribile epidemia di peste che ne falcidiò la popolazione), da cui sembrò riprendersi nel XVIII sec. con l'arrivo dei Savoia. Soprattutto durante il regno di Carlo Emanuele III (1730-73) e il ministero del conte Bogino (1759-73) si avvertirono segni di sviluppo dell'economia agraria e della vita civile, grazie all'istituzione dei "Monti frumentari", all'incoraggiamento delle nuove colture (gelsi, patate), al restauro dello scalo portuale di Torres, alla incentivazione del commercio e alla riapertura dell'Università (1765). Negli anni 1793-1802 Sassari fu però al centro delle rivolte antifeudali delle campagne logudoresi e la repressione sabauda fu spietata. Nella prima metà dell'Ottocento si verificò un notevole sviluppo urbanistico, grazie a un progetto di ampliamento della città del 1836 orientato in direzione Sud-Ovest, cioè verso la "strada reale" che dal 1829, anno della sua ultimazione, collega Sassari con Cagliari (ancora oggi SS 131 "Carlo Felice"). Il periodo successivo fu caratterizzato da continui scontri tra conservatori e democratici e Sassari andò acquisendo la fama di città repubblicana; nel 1851 venne altresì fondata da artigiani e operai la "Società operaia di mutuo soccorso". Nella seconda metà del secolo venne demolita la quasi totalità delle mura e abbattuto il castello aragonese (del 1330 circa), mentre nel ventennio fascista la popolazione di Sassari continuò a crescere - 51.700 abitanti nel 1931 - e con essa l'edilizia pubblica e privata. Tre nuovi piani regolatori, elaborati tra il 1929 e il 1942, definirono lo sviluppo periferico con la creazione del nuovo quartiere popolare di Monte Rosello - collegato alla città da un ponte inaugurato nel 1934 - e del quartiere residenziale di viale Italia-Porcellana. L'intervento nel centro storico rispose invece alla logica del "piccone risanatore", con lo sventramento di un ampio comparto adiacente al Duomo e al corso Vittorio Emanuele II, noto come piazza Demolizioni (oggi piazza Mazzotti). Nel secondo dopoguerra Sassari, nonostante i limiti e le contraddizioni del suo sviluppo economico, ha marcato una certa vivacità culturale e politica: i sassaresi Antonio Segni, Enrico Berlinguer e Francesco Cossiga, tra gli altri, sono stati tra i protagonisti della scena pubblica dell'Italia repubblicana. Nello stesso periodo la popolazione della città è pressoché raddoppiata.
ARTE.
Risale al XV secolo la fioritura del gotico-catalano nell'architettura civile e religiosa che ancora oggi connota la parte più antica della città. Ne resta ampia testimonianza anche nel monumento più conosciuto di Sassari, ovvero il Duomo di San Nicola, che al suo interno custodisce, tra gli altri tesori, un gonfalone del XV sec. e una statua argentea di San Gavino del 1600. Tra le città sarde, Sassari fu inoltre quella più in sintonia con le esperienze dell'umanesimo e con i modelli culturali del rinascimento italiano: gli echi della classicità cinquecentesca si possono scorgere in alcuni edifici del centro storico, come Palazzo d'Usini, nell'antica "carra manna" (oggi piazza Tola), nella fontana del Rosello o nella facciata della chiesa gesuitica di Gesù e Maria (oggi Santa Caterina).
LA PROVINCIA.
La provincia di Sassari (dal 2005) conta 66 comuni, 323.626 abitanti (il 19,8% della popolazione sarda) e si estende nel Nord-Ovest dell'isola per 4.281 kmq (il 18% circa del territorio sardo). Fanno parte del territorio provinciale l'Isola dell'Asinara, il Lago Cuga, il Lago Bidighinzu e il versante occidentale del Lago del Coghinas. L'economia è prevalentemente agricola (cereali, ortaggi, patate, vino, olio, frutta, agrumi) ed è molto diffusa la pastorizia. La pesca è praticata lungo le coste (tonni, aragoste, corallo). Le industrie principali sono quelle del sughero, lattiero-casearia, conserviera e alimentare in genere. Attiva è la produzione artigianale: lavorazione del corallo, mobili, tappeti, arazzi, produzione di oggetti in ferro battuto, ceramiche. Di notevole importanza è l'industria turistico-alberghiera nelle località balneari. Fra i centri principali ricordiamo: Alghero, Porto Torres, Sorso, Ozieri, Ittiri, Castelsardo, Valledoria.
Veduta di Castelsardo (Sassari)
La spiaggia di Stintino (Sassari)
Luoghi d'interesse
La Cattedrale di S. Nicola
Nel centro della città, che mantiene un aspetto caratterizzato da vie strette e irregolari (retaggio del periodo spagnolo), si trova il Duomo intitolato al patrono cittadino San Nicola. Riedificato tra il 1480 e il 1505 su una pieve romanica del secolo XII, il Duomo di Sassari riprende modelli architettonici del gotico aragonese. Risale invece al Duecento la parte inferiore del campanile, poi ripreso e completato nel 1756 con una snella sopraelevazione ottagonale. Tra il 1681 e il 1715 si svolsero i lavori che portarono all'attuale facciata: l'architetto, quasi sicuramente Baldassarre Romero, seppe fondere in maniera originale i motivi plastici decorativi del tardo Barocco spagnolo con il repertorio goticheggiante e classico. Sul portico in basso con volte stellari si eleva l'alta fronte minutamente coperta da intagli, su cui si aprono tre nicchie con le statue dei santi Gavino, Proto e Gianuario, mentre nel fastigio superiore, ad arco, troneggia la statua di S. Nicola. L'interno del Duomo è a navata unica e cupola su tamburo. Sull'altare maggiore è da ammirare la Madonna del Bosco, tempera su tavola di scuola senese del Trecento; in una teca è situata la statua di San Gavino, realizzata in argento nel XVII secolo; il coro è opera di ebanisti sardi di inizio Settecento. Alla Cattedrale è annesso il Museo del Tesoro del Duomo, che raccoglie importanti pezzi di argenteria (sec. XVI-XIX), paramenti sacri e opere d'arte di pregio, come il famoso Stendardo processionale dipinto a tempera e olio su tavola, capolavoro di un anonimo artista della fine del Quattrocento.Il duomo di S. Nicola a Sassari, in stile gotico aragonese
Piazza Castello
La piazza prende il nome dall'antico castello aragonese costruito intorno al 1330, già sede del tribunale dell'Inquisizione, demolito nel 1877, che sorgeva sul sito dell'attuale caserma La Marmora, nel cui cortile si conservano gli stemmi dell'antica facciata. All'interno della caserma si può visitare il Museo storico della Brigata Sassari, dedicato alle eroiche gesta dei fanti sardi nella guerra 1915-18. Sul lato sinistro della piazza si trova la chiesa della Madonna del Rosario, con facciata dei primi del XVIII sec., che conserva al suo interno uno splendido altare maggiore barocco in legno dorato, opera di artigiani locali (1686).Corso Vittorio Emanuele II e dintorni
Era la via principale della città medievale (denominata Platha de Codinas, perché scavata nel tufo), che, lungo l'asse Sud-Nord, tagliava Sassari in due. Alla sua metà si apriva la piazza del Comune con il Palazzo di Città (area su cui ora sorge il Teatro civico, in stile neoclassico sul modello del Carignano di Torino). Nella parte superiore della via (l'attuale piazza Azuni) sorgevano la demolita chiesa gotica di S. Caterina e il Palazzo del Podestà, sede in seguito del governatore del Capo di Logudoro. La maggior parte delle case aveva portici con botteghe di mercanti e artigiani. Si sono conservate fino ai nostri giorni alcune abitazioni gotiche del XV sec., come quella in via Canopolo (n. 20) e quella nota come Casa Farris (n. 23), con belle finestre e bifore di stile gotico catalano, che mostra murati gli antichi portici. Di fronte al Teatro civico si eleva il Palazzo di S. Sebastiano, del secondo decennio dell'Ottocento; mentre alla sua destra spicca la facciata barocca della chiesa di S. Andrea (1648), ispirata a modelli liguri. La via termina allargandosi nella piazza S. Antonio: a sinistra un frammento della cinta muraria medievale con una torre merlata; al centro, la colonna di S. Antonio (1954) del sassarese Eugenio Tavolara. Dinanzi alla piazza sorge la chiesa di S. Antonio Abate ultimata nel 1709, con una facciata semplice e ben proporzionata di gusto barocco. Capolavoro dell'apparato decorativo della chiesa è il retablo dell'altare maggiore, in legno intarsiato e dorato, del genovese Bartolomeo Augusto. Nella sagrestia invece sono custoditi il Santo diacono, attribuito al pittore Giovanni Muru (prima metà del XVI sec.), e l'Addolorata di Giovanni Marghinotti.Fonte di Rosello
Dalla caratteristica via Rosello (l'antica via degli argentieri), si sale la settecentesca rampa di scale che fiancheggia la chiesa della Trinità (con un'interessante facciata barocca dell'inizio del XVIII sec.) e si arriva alla fontana. Già nota nel 1295, nel 1605 venne ricostruita da lapicidi genovesi su scala monumentale. Dalle severe forme manieristiche tardo-rinascimentali, la fontana è un monumento originale, sia per gli elementi simbolici rappresentati, sia per le varie integrazioni artistiche che sintetizza: è costituita da due parallelepipedi sovrapposti, in marmo bianco e verde, coronati da due archi incrociati, con al culmine una statua equestre di San Gavino (quella attuale è una copia del 1975 dell'originale perduto). Agli spigoli della base vi sono le statue delle Stagioni, copie eseguite nel 1828 di originali distrutti nei moti del 1795-96. L'acqua sgorga continuamente da dodici bocche di leone.Le mura medievali
Il luogo in cui si possono osservare i frammenti della cinta muraria medievale della città è corso Trinità. Iniziate dai pisani nel XIII sec., vennero completate dai genovesi nei primi decenni del XIV. Dal vicolo Godimondo è possibile vedere i camminamenti interni e la singolare successione delle piccole case addossate alle mura. Una torre, appena più alta delle mura, si presenta come una sorta di corpo avanzato. Poco oltre sono murati tre stemmi trecenteschi.Piazza Tola
Era l'antica "carra manna", dove era posta la misura pubblica, e costituiva il cuore della vita urbana nel medioevo e nell'età moderna. Al centro della piazza si trova il Monumento a Pasquale Tola, storico e magistrato sassarese, opera di Filippo Giulianotti (1903). Notevole il Palazzo Manca di Usini, costruito nel 1577, che costituisce un raro esempio di architettura civile e tardo-rinascimentale in Sardegna; l'edificio ospita la Biblioteca comunale con una ricca collezione di volumi, periodici, stampe, fotografie e manoscritti riguardanti soprattutto la storia cittadina.Chiesa di S. Caterina
Già chiesa di Gesù e Maria, fu costruita tra 1580 e 1609 per la Compagnia di Gesù, su progetto di Giovanni de Rosis e secondo moduli controriformistici; la realizzazione a opera delle maestranze locali ne spezzò l'austera impronta manieristica. Nell'interno le coperture della navata centrale e delle cappelle con volte a crociera, gli archi del transetto e del capocroce rivelano l'innesto sul progetto originale di elementi di derivazione gotico-catalana. Pregevoli i dipinti del gesuita fiammingo Giovanni Bilevelt (attivo a Sassari tra il 1622 e 1652), tra cui l'Incoronazione della Vergine e la Trinità.![]()
Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.
Guadagnare acquistando online.
![]()
Palazzo Ducale
Palazzo Ducale (o del Comune), dal 1900 sede del Municipio, fu fatto costruire dal duca dell'Asinara e rappresenta il più rilevante esempio di architettura civile settecentesca della città. A dirigere la costruzione dal 1775 al 1805 fu probabilmente Carlo Valino, che introdusse nell'edilizia sassarese schemi di derivazione piemontese. La sobria facciata a tre piani, orizzontalmente scandita da fasce e verticalmente da lesene, presenta le finestre del primo piano sormontate da timpani ad arco a cuspide e quelle del secondo incorniciate da un motivo rococò. L'androne, da cui parte una scala a tenaglia, si affaccia su un armonico cortile.Santa Maria di Betlem
Fondata assieme al convento nel 1106 dal 'giudice' Costantino e affidata ai Benedettini, passò negli anni Venti del XIII sec. ai Francescani. Il complesso svolgeva una funzione istituzionale, raccogliendo attorno a sé i lavoratori organizzati nei "gremi" (corporazioni e associazioni medievali sarde); in continuità col passato, oggi il suo ruolo si esercita nell'annuale Festa dei Candelieri: la sera del 14 agosto i grandi candelieri votivi di legno intagliato, che qui si conservano, vengono portati in processione dai rappresentanti dei gremi vestiti in costume. La parte inferiore della facciata risale al 1236-38 ed è il frammento più antico dell'edificio. Sopra un ordine di arcatelle a tutto sesto si innesta la parte superiore ricostruita nel 1465 con un grande rosone e un timpano. Decorazioni e archetti coevi si sviluppano lungo il fianco sinistro, sul cui portale è stato recentemente posto un medaglione a rilievo raffigurante la Madonna. Tra il 1829 e il 1834 si collocano gli interventi di Antonio Cano che rimaneggiò il presbiterio e costruì la cupola ornandola di numerose statue. Conserva ancora l'originale carattere catalano la Cappella dei Muratori, subito a sinistra dell'ingresso; le altre sei cappelle che si aprono sulla navata appartengono ad altrettanti gremi artigiani e vantano altari barocchi intagliati. Nella cappella a sinistra dell'altare maggiore si conserva un gruppo ligneo della Madonna col Bambino della prima metà del XV secolo. Interessante anche il pulpito barocco, opera del sassarese Antonio Giovanni Contena (1741). Nell'elegante sagrestia settecentesca, si trova una Madonna in gloria e quattro santi, dipinto di Giacomo Cavedoni. Da qui si accede al chiostro, in gran parte murato, che conserva lapidi con iscrizioni medievali, catalane e spagnole: al centro, la Fontana del brigliadore (dal catalano "brillador", zampillo), opera del XVI secolo.Palazzo dell'Università
La nascita dell'Università di Sassari è legata al testamento del sassarese Alessio Fontana (1558), che lasciò tutte le sue proprietà per fondare un collegio universitario. I corsi tenuti dai Gesuiti iniziarono nel 1565; del 1617 è il diploma di Filippo III di Spagna, riconoscimento ufficiale dell'Ateneo. Alla fine del XVII sec., il prestigio dell'Università era alquanto decaduto e soltanto in seguito alla riorganizzazione sabauda del 1765 riprese nuovo slancio. L'edificio, costruito tra il 1559 e il 1566 su progetto di Fernando Ponce de Léon, e ampliato nel '600, si articola attorno a un chiostro circondato da un doppio ordine di logge. Un ampio scalone conduce al piano superiore, dove l'Aula Magna (1929) è decorata con tele di Mario Delitala. Nel Rettorato si conservano ritratti di sovrani sabaudi, fra cui quelli di Vittorio Amedeo III di Giovanni Antonio Molinari (1774-75) e di Carlo Felice di Giovanni Battista Biscarra (1830), la marmorea statua di Ebe (1836 circa) di Andrea Galassi e la mazza d'argento con i simboli delle facoltà (1765) del piemontese Giovanni Michele Graneri. La Biblioteca universitaria ha un patrimonio librario di oltre 250.000 volumi; fra i manoscritti, il celebre Condaghe di San Pietro di Silki (XI-XII sec.), uno dei primi documenti in volgare sardo.San Pietro in Silki
La chiesa, il cui appellativo parrebbe derivato dallo scomparso abitato medievale di Silki, esisteva già nel XII secolo. La semplice facciata che si apre con un grande atrio è del 1675; delle precedenti fasi costruttive restano la parte inferiore del campanile risalente al secolo XIII, dai caratteri romanico-lombardi, e le strutture murarie della navata, edificate negli anni immediatamente precedenti il 1477. L'interno è una spaziosa aula coperta a botte lunettata, con quattro cappelle sul lato sinistro. La prima, dedicata alla Madonna delle Grazie, rappresenta uno dei più armoniosi esempi del gotico catalano in Sardegna, grazie anche ai rilievi scolpiti nella grigia pietra calcarea dei capitelli e della gemma della volta (seconda metà del XV sec.). Assai pregevole è l'altare maggiore in legno intagliato del XVII sec., nel quale è collocata la venerata immagine della Madonna delle Grazie. Di fronte alla chiesa sorge l'attuale convento dei Frati Minori, nel quale è custodita una Visitazione di anonimo pittore della prima metà del XVI secolo.Museo Archeologico Etnografico Nazionale "Giovanni Antonio Sanna"
Istituito nel 1878, il museo comprende una notevolissima sezione archeologica, prevalentemente derivante dai territori della provincia di Sassari, una pinacoteca e delle raccolte etnografiche. Nella sala preistorica sono presenti i materiali più antichi rinvenuti in Sardegna, dalle foreste pietrificate ai manufatti collacabili tra il Paleolitico inferiore e il tardo Neolitico; la sala Monte d'Accoddi è dedicata allo straordinario omonimo tempio preistorico; nella sala delle tombe ipogeiche si trovano materiali provenienti dalle necropoli a domu de janas, prevalentemente dell'età del rame e del primo bronzo; la sala delle tombe megalitiche è dedicata a tombe di giganti e dolmen; la sala nuragica contiene ceramiche, reperti litici e bronzi nuragici (notevoli il modellino del nuraghe Palmavera e il Trofeo di Padria). Vi sono poi una sala fenicio-punica, una sala romana e una medievale, nonché un ricco medagliere (con materiali dall'età fenicio punica all'età moderna) e la pinacoteca con oltre 360 dipinti, dal XIV sec. all'età contemporanea.Regione Sardegna
Sardegna - Turismo
Italia - Turismo
Italy - Italia
Earth Quake Live - Terremoti
La Nuova Sardegna
Unione Sarda
Casteddu online
Cagliari Quotidiano Net
Sardegna Oggi
Sassari Notizie
Il Messaggero Sardo.com
Olbia Nova
Olbia
Olbia Notizie
Gallura Oggi
Vista Net
La Provincia del Sulcis Iglesiente
Gazzetta del Sulcis
La Gazzetta del Medio Campidano
Villacidro Info
Videolina TV
Catalan Tv
Canale 40 TV
Radio Kalaritana
Radiolina
Radio Manila Fm
Radio Sintony
UniCa Radio
Radio X
Radio Studio 96
Radio Barbagia
Radio Arcobaleno
Radio Club
Radio del Golfo Net
Radio Fusion
Radio Golfo degli Angeli
Radio Iglesias
Radio Nuoro Centrale
Radio Luna Carbonia
Radio Planargia Net
Radio Vita Nuova
Radio Italia Anni Sessanta
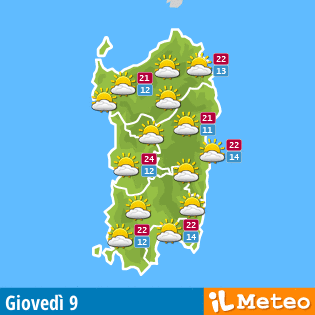
![]()
![]()
Enciclopedia termini lemmi con iniziale a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Storia Antica dizionario lemmi a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Dizionario di Storia Moderna e Contemporanea a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z
Lemmi Storia Antica Lemmi Storia Moderna e Contemporanea
Dizionario Egizio Dizionario di storia antica e medievale Prima Seconda Terza Parte
Storia Antica e Medievale Storia Moderna e Contemporanea
Dizionario di matematica iniziale: a b c d e f g i k l m n o p q r s t u v z
Dizionario faunistico df1 df2 df3 df4 df5 df6 df7 df8 df9
Dizionario di botanica a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z
![]()




